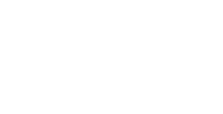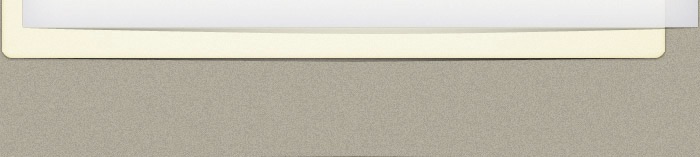Testo di presentazione della mostra alla Fondazione il Bisonte
di Julie e Pierre Higonnet (2007)
(leggere il saggio di Maxime Préaud: un cane che sognecchia)
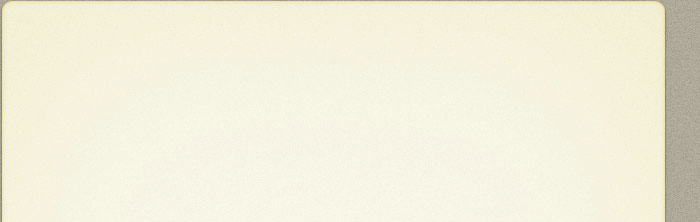

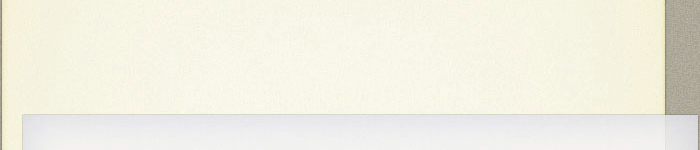
Testo di presentazione della mostra alla Fondazione il Bisonte
di Julie e Pierre Higonnet (2007)
(leggere il saggio di Maxime Préaud: un cane che sognecchia)
Le Melanconie di Jean-Pierre Velly
« Voglio dire che il topo o l’uomo (può sembrare terribile da dire, l’uomo generalmente non ama che gli si dica la verità in faccia) sono assolutamente uguali… Come il pipistrello; sono uguali. Il topo uguale a uno e l’uomo uguale a uno… E la pianta uguale a uno. E tutto…anche la pietra… Il pezzo di ferro pure…è uno. Ovviamente, per il nostro piccolo egoismo personale… non c’è assolutamente più alcun problema, per me, da questo punto di vista!
E questo si sa, o almeno io lo so.»
Jean-Pierre Velly
Parole raccolte da Michel Random, incontro del 12 novembre 1982
La Malinconia nell’arte occidentale è stata recentemente oggetto di un’importante mostra a Parigi e a Berlino. In effetti, “una volta spenti gli artifici del Giubileo dell’anno 2000, era tempo che si riparlasse della Malinconia[1]”, questo umore, questa bile nera, questo languore, questo spleen che oscilla dallo svago alla nostalgia fino alla temibile psicosi maniaco-depressiva. Questo tema, come è stato ampiamente dimostrato in occasione di questa ragguardevole esposizione, assilla tutta la storia dell’occidente. Ma si sarebbe tentati di aggiungere che esistono pochi esempi di un’opera (e tramite essa di una vita) tanto sottomessa, dall’inizio alla fine, ai rigori dell’implacabile regno di Saturno, quanto quella di Jean-Pierre Velly.
Angoscia esistenziale, velo di stanchezza e di noia gettato sul mondo, la Malinconia si declina secondo numerose modalità attraverso i secoli. È questo umore che anima i grandi maestri del passato che Velly ammira, ed è con assoluta naturalezza che essa si inscrive fin dagli esordi nell’opera dell’artista. La prima incisione catalogata, il «Paysage à l’arbre mort» del 1961, oggi dispersa, è già un soggetto malinconico.
Il destino di Velly era suggellato. Che si tratti di incisioni o di disegni, di acquerelli o di oli, la sua opera (che si sviluppa per una trentina d’anni) emana un pertinace sentimento saturnino, sia attraverso la scelta dei soggetti, l’espressione e la gestualità delle figure, che attraverso il trattamento della luce, che conferisce alle sue immagini una dimensione fantastica. Ovunque questo sentimento innato di finitezza penetra le languide figure femminili, i paesaggi morbidi, gli annegati ispirati alle poesie di Corbière, gli alberi secchi, gli insetti trafitti, i fiori appassiti. Le incisioni di Velly sono variazioni sul tema della transitorietà e l’uguaglianza fondamentale degli elementi costitutivi del mondo, dove maestria ottica del visibile e presentimento di morte, formano una coerente estetica del dolore.
In un autoritratto a matita del 1987 - l’artista aveva allora 44 anni - si raffigura con tratti esageratamente invecchiati, come se avesse vissuto per un secolo. L’atteggiamento ieratico, lo sguardo ombroso e infossato, la piega amara delle labbra, un cranio appena schizzato, l’orologio da polso scarno, tutto ci ricorda la brevità dell’esistenza. Giunto al termine della sua aspirazione alla conoscenza, egli si è rassegnato alla misura dei propri limiti. È lo sguardo stanco di colui che ha ritrovato la saggezza prima e che, da allora, vive in un esilio di disperazione. Vittorio Sgarbi, a proposito di questo stesso autoritratto, scrive nel 1988: «L’espressione di Velly è quella del gran malinconico; il tormento sulla sua faccia si stampa con una punitiva drammaticità, come in una autobiografia passata attraverso l’iconografia dell’ Ecce Homo.[2]»
«I malinconici sono gli infelici che pensano, ma lo spirito dell’artista sa trasformare il dolore in opera»[3]. L’opera di Velly si presenta come una lunga serie di vanitas. Il messaggio delle vanità olandesi del XVII secolo è teso a ricordare la transitorietà delle cose, l’importanza del distacco dal mondo dei sensi e delle ricchezze. Ma la compiacenza dell’artista di genere lusinga: l’occhio ricerca la carezza dei broccati, lo splendore delle coppe, la voluttà dei frutti, la dolcezza dei petali, il realismo della chiocciola. Nel bianco e nero l’ascesi è totale: senza artificio, la seta perde la sua lucentezza, la conchiglia non è più l’illusione di una conchiglia reale, ma l’idea di una conchiglia, anche se gli oggetti sono qui rappresentati scrupolosamente, perfino con un soprappiù di realtà, seguendo prospettive multiple ma perfettamente rispettate.
Lo smembramento e la decomposizione dei corpi, il degrado dovuto al tempo, l’abisso e la caduta sono al centro delle preoccupazioni dell’artista. «Rovine, cadaveri, fantasmi, mostri e scheletri, sono l’universo mentale del melanconico »[4]. Si potrebbero aggiungere a questa lista gli alberi morti, i cieli burrascosi e i mari in tempesta. Se ne vedranno qui in abbondanza. Le lastre sono popolate di incongruenze allucinanti. Entro paesaggi austeri dai panorami vertiginosi, dalle prospettive oblique, dagli orizzonti molteplici, i volti sono deformati e i corpi soggetti all’anamorfosi, gli oggetti ingranditi o ridotti a volontà. È un mondo fantastico, con la precisione diabolica di un orafo maniacale.
E se Velly si ricollega al memento mori così come lo si intendeva nel XVII secolo, coi suoi vasi di fiori (Fleurs 1971, Vase de Fleurs 1983), o la presenza del teschio in Débris (1970), è proprio di una vanitas moderna che si tratta nel caso di Tas d’ordures (1969), o di Senza Rumore I e II (1969) dove una moltitudine di oggetti di vita quotidiana, scarti prematuri della nostra civiltà, sono abbandonati nella natura, a perdita d’occhio. Vanità come pure quella delle donne adagiate (Rosa au Soleil, 1968; Trinità dei Monti, 1968, le quattro Métamorphoses, 1970) che rivolta, sventra, dissecca, fa esplodere, per mostrare la loro “faccia” nascosta, il rovescio dei corpi. Vanità e melanconia camminano qui fianco a fianco, e poco importa che vadano incontro all’assurdo, frutto di questa agitazione insensata che è la vita.
Il mondo sensibile è un mondo di colori e di volumi; ma il nero, il bianco e la loro fusione nel grigio, sono proprio le tinte della Malinconia. In questo senso non sarà forse l’incisione l’arte malinconica per natura?[5] È a partire dall’età di 21 anni che Jean-Pierre Velly si consacra esclusivamente alla stampa in bianco e nero. La sua opera incisa è ricca di 97 incisioni ,[6] dapprima su zinco, poi molto presto su rame, realizzate fra il 1961 e il 1990. La maggior parte è stata eseguita dal 1964 al 1973, a bulino (quasi sempre sbarbato), all’acquaforte e, spesso, con una combinazione di entrambi. Alcuni rami sono stati abbozzati o ripresi a puntasecca. Ci sono anche due belle maniere nere. L’acquatinta non compare che due volte sulle sue lastre. Rondels pour Après (1978), infine, è l’unica incisione la cui tiratura sia stata stampata a più colori.
A partire dal 1971 Velly si cimenta in altre tecniche, in particolare nella punta d’argento. Si tratta soprattutto di ritratti realistici di donne, bambini, vecchi e di qualche paesaggio. Il colore s’insinuerà dolcemente nella sua opera attraverso il disegno (grafite acquerellata o matite a colori in Velly pour Corbière (1978), che lo condurrà verso l’acquarello e poi verso la pittura ad olio. Ma se pure il ritmo della produzione di stampe rallenta, egli non cesserà mai di incidere, fino al 1990, anno della sua scomparsa.
In occasione di questa mostra alla Fondazione Il Bisonte sono state selezionate trentaquattro incisioni. L’opera di Velly forma un insieme molto coerente sia sul piano formale che concettuale. Un’opera ne genera un’altra; un motivo abbozzato nell’una sboccia nella seguente. Si può dunque prendere in esame il suo corpus secondo una grande varietà di approcci.
L’esposizione antologica dell’ opera incisa tenuta al Musée d’Art Roger Quilliot di Clermond-Ferrand nel 2003 era stata presentata da un’angolazione tematica.[7] L’attuale esposizione sarà invece affrontata da un punto di vista stilistico. Tale approccio consentirà la presentazione dell’universo dell’artista isolando fra le sue incisioni i ricorsi formali. Cinque saranno i leit-motivs evidenziati, per quanto questi si compenetrino fra loro. Il primo, sviluppato più in profondità da Maxime Préaud nel suo saggio sottolinea i legami che uniscono le stampe di Jean-Pierre Velly alla tradizione dell’incisione, in particolare a quella della Scuola del Nord e del Rinascimento italiano.
Jean-Pierre Velly all’epoca della sua formazione, agli inizi degli anni sessanta, opta per un’espressione grafica fedele a quella della tradizione, col suo bagaglio tecnico impegnativo. Egli frequenta quattro scuole d’arte, si forma non soltanto coi suoi professori, ma prende lezioni anche dai maestri del passato. Egli si situa subito come un anello nella lunga tradizione dell’incisione, cosa che conferisce alle sue opere una vocazione atemporale.[8] Si appassiona giovanissimo all’opera di Dürer[9] che lo convince a consacrarsi all’incisione.
Così, nelle stampe del periodo francese (dal 1964 al 1966) ritroviamo echi di Leonardo nella serie delle Grotesques (1964-1965), di Bresdin (Paysage Rocheux, 1965), di Bosch e Schongauer (Mascarade pour un rire jaune, 1967), senza dimenticare Goya (Chute, 1965). Main Crucifiée (1964) e Etude de pieds en croix (1965) sono un’allusione diretta all’Altare di Isenheim di Mathias Grünewald,[10] che l’artista ammirava in modo assoluto. Vi si ritrova tutta la tensione, il dolore e l’ “espressionismo” di quelle carni torturate.
La composizione di Vieille Femme (1966) e de La Clef de Songes (1966), scissa in due, dove una donna matura è paracadutata nel cielo al di sopra di un paesaggio visto molto dall’alto, evoca quella della Nemesi (1502) di Albrecht Dürer. Le Groupe de six hommes (1964) corrisponde al Bagno degli Uomini (1496). La diavolessa[11] di Illustration pour un conte (1965) adotta la celebre posizione della Melanconia I (1514), ma è anche la contrazione di Giobbe [12], silografia del 1509, di Hans Baldung Grien. Ma le sue affinità con Dürer (e la Scuola del Nord) vanno ben più lontano. Al di là di un’affinità di stile, si tratta di una fratellanza in spirito. Sono entrambi dei mistici della natura che posano lo stesso sguardo attento sul minimo filo d’erba, le variazioni del cielo e delle nuvole, la fragile bellezza degli insetti.
Il Reversibile
È impregnandosi di questo vocabolario ereditato dai maestri antichi che Velly costruisce il proprio linguaggio, veicolo della propria introspezione personale[13]. Sovvertendo i generi classici (nudi, paesaggi, nature morte) egli ne rinnova il senso. È un tema molto italiano quello che riprende con la serie delle donne sdraiate, realizzata durante il suo soggiorno a Villa Medici. In Rosa au Soleil, capolavoro del 1968, Rosa, la giovane moglie dell’artista, nuda si pettina sotto un sole abbagliante; in secondo piano compare il suo doppio, come in un effetto speculare. Acefalo, questo svela le proprie viscere, ed è tutto un assemblaggio osceno di organi, di cavi, di rottami che appare alla luce del sole. Nessuna distinzione viene fatta fra materia organica e inorganica in questa sorta di disimballaggio, collocato nell’impero del sogno e dell’incubo. La scena ricorda senza dubbio che la bellezza esteriore dell’una non deve celare la realtà dell’altro.
Ricordiamo che l’inversione è una delle caratteristiche principali dell’incisione. L’artista lavora a rovescio, e ciò a più livelli. Egli incide il rame da tutte le parti, facendolo spesso ruotare. La stampa della matrice di rame sotto il torchio è un lavoro fatto al negativo. Certe incisioni di Velly sono rovesciabili e sottolineano in tal modo l’equivalenza fondamentale degli elementi, perché ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Rechute (1968) e Le ciel et la mer (1969) obbediscono a questa legge: nella prima, un nugolo di corpi precipita in un baratro infernale. Rovesciando l’immagine, cadono questi stessi uomini, ma stavolta nel mare. Il brano può essere letto indifferentemente nei due sensi.[14] Nella seconda, le nuvole nere del cielo sono talmente tormentate da arrivare a contaminare i cavalloni del mare. Ne L’Ange et Linceul (1973), il rovesciamento si opera tramite una contrazione linguistica: le fasce (langes) sono i primi abiti, il sudario l’ultimo.
III. Metamorfosi
Il principio femminile simboleggia la fluttuante mobilità delle cose, il processo naturale della trasformazione. Ma questi corpi di donna sono bambole, manichini da atelier. La loro sostanza interna risplende alla luce del sole sotto l’effetto di una tempesta. Dopo aver sconvolto il tema della donna sdraiata per svelarne la realtà nascosta, Velly stavolta si accinge a frantumare i corpi. Nelle quattro Métamorphoses, sotto l’effetto di un ciclone, una raffica di corpuscoli, viscere, personaggi, forme organiche e geometriche, si sprigionano dai nudi femminili mutilati.
L’unità, trasformandosi, non produce un’altra unità, come nelle Metamorfosi di Ovidio[15], bensì una molteplicità. In Métamorphose I, questo agglomerato di elementi diviene il substrato sul quale crescono degli alberi. Così la morte non sarà la fine ultima, bensì una tappa necessaria alla rigenerazione, al ciclo della vita, proprio come l’inverno, alle nostre latitudini, è il periodo vegetativo che precede la germinazione della primavera. In Métamorphose II, si assiste all’istantanea di un violento vortice di forme e di faville, spirale ascendente dalla terra verso il cielo. In Métamorphose III, è una corrente d’aria che precipita e trascina giù un flusso continuo di figure femminili e drappeggiate, mentre in Métamorphose IV, è un’onda che trascina tutto e si frange e produce a sua volta una schiuma che risale verso il cielo.
Ne Les Temples de la nuit (1979), una donna annegata è portata da flutti ingombri di teschi e oggetti contundenti. I flutti si innalzano verso una nube fantastica situata nella parte superiore, che libera a sua volta la pioggia che alimenta il mare. Questa Ofelia si integra nel ciclo delle rigenerazioni. La morte dona la nascita alla vita.
Ma questo passaggio dall’uno al molteplice potrebbe avere altri significati. Procedendo così, Velly manda in frantumi il concetto dell’unità antropocentrica, unità di riferimento per ciascuno di noi. Poiché prescindere da sé stessi è la cosa più difficile. Illusorio anche pensare che l’uomo sia il centro della creazione. Egli non è che un elemento fra gli altri, una fase nel ciclo di generazione-distruzione.
IV. Accumulazioni
L’accumulazione è un’altra “figura di stile” caratteristica dell’arte di Jean-Pierre Velly. Questo horror vacui, così adatto al fantastico, si sviluppa molto presto nell’opera dell’artista. Egli incide degli ammassi straordinari di oggetti, di rovine, o di personaggi, concentrati in pochi centimetri quadrati.
Il Massacre des innocents (1970-1971) è oggi la più celebre delle sue incisioni; in questa lastra spettacolare che egli impiegò un anno a terminare, un paesaggio si estende all’infinito; è costituito da molte migliaia di personaggi nudi che corrono in tutte le direzioni. Questo paesaggio antropomorfico e allucinato è bagnato da una luce da fine del mondo.
Ma l’accumulazione giunge al parossismo in Un point c’est tout (1978) dove centinaia di oggetti, di personaggi e di animali sono aspirati verso un solo punto di fuga.
Come in Enfin (1973), il caos non è che apparente. In realtà, l’opera è attraversata da parte a parte da ramificazioni, reticolati, significati riposti. Analizzando la posizione degli oggetti nell’incisione, si scopre ben presto che questi sono legati da associazioni morfologiche, linguistiche e semantiche. Velly ha d’altro canto materializzato la profusione di tali legami con corde, catene di bicicletta, cavi, tubi e pulegge. Questo labirinto possiede un sistema di riferimento e di simboli suo proprio.
Queste accumulazioni di personaggi, piante, animali e oggetti della vita ordinaria, formano un vero e proprio “gabinetto di curiosità”. L’opera di Velly, attraverso la contemplazione della natura e la rimessa in discussione dei valori e delle scale, ci permette di prendere coscienza del mondo nella sua totalità.
V. Scale
La tabula rasa di Jean-Pierre Velly non risiede dunque nel suo vocabolario grafico, improntato ai grandi maestri del passato, ma nella sua capacità di sconvolgere scale e valori.
La loro rivalutazione è la risultante di questa meditazione incisa. Grazie al sovvertimento delle scale ottiche, Velly concentra nello stesso spazio l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande. Microcosmo e macrocosmo si confondono.
La nozione di scala fa la sua comparsa molto presto nell’incisione di Velly; le Escargots (1964), posate in un paesaggio di scogliere a picco, appaiono sovradimensionate; gli uomini nudi rappresentati in Petit paysage d’Ollioules (1965) o in Paysage rocheux, si perdono in una natura immensa dall’aspetto spesso inquietante. La scala sociale è rappresentata in Le bas de l’échelle (1967), dove mostri dai volti alterati, abbietti, ci squadrano e ci mettono a disagio. In Vase de fleurs (1983), si assiste ad un altro rovesciamento di valore: un mazzo d’ortiche, erbe di campo e erbe spontanee da ciglio di strada, dentro un vaso, occupa il primo piano, davanti ad un paesaggio che si stende a perdita d’occhio. Uno sfasamento si verifica fra i piani perché si è perduta l’intermediazione della misura umana. È guardando attentamente questo bouquet da quattro soldi che si scopre la sontuosità del lavoro della natura e, per suo tramite, quello dell’artista. Questa nozione è esacerbata ne Le rat mort (1986), intitolata anche Au dernier souffle du rat mourant sous les étoiles, dove in uno scorcio stupefacente, il topo odiato dagli uomini si misura all’universo. In maniera speculare, una rivoluzione si opera anche sullo spettatore. Egli può allora considerare il mondo sotto una luce differente e vedere finalmente la bellezza perfino là dove non se l’aspettava più.
*
Velly avrebbe cercato per tutta la vita di tradurre il mistero, il segreto, l’indicibile. Molto pazientemente egli ha saputo comporre un’estetica della fine delle cose. Perché come dice giustamente Vittorio Sgarbi: «Tutto ciò che è, è sul punto di finire…La vera bellezza è soltanto questa: non il nulla, ma ciò che è sul punto di scomparire[16].» La contemplazione sulla sparizione e la morte è una condizione di rinascita. Questa malinconia positiva è fondata su un’analisi, una comprensione ed una accettazione della realtà nella sua globalità che permette l’ammirazione di ogni cosa, piccola o grande che sia. Il passaggio al colore si comprende allora come un progresso naturale; l’incubo in bianco e nero cede il posto a magnifici disegni di nudi, di vasi di fiori delicati, di paesaggi grandiosi, di crepuscoli commoventi.
I nostri più vivi ringraziamenti alla Famiglia Velly, al professore Rodolfo Ceccotti e a Simone Guaita della Fondazione Il Bisonte, alla dottoressa Marzia Faietti, direttrice del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, al professor Maxime Préaud, conservatore del Gabinetto delle Stampe della Biblioteca Nazionale di Parigi, a Bernard Micaud, direttore dell’Istituto Francese di Firenze, ai servizi culturali dell’Ambasciata di Francia a Roma (Palazzo Farnese) e dell’Accademia di Francia a Roma (Villa Medici).
[1] Jean Clair, Introduzione a «Mélancolie, génie et folie en Occident», Gallimard RMN 2005, p. 11
[2] Vittorio Sgarbi, Velly oltre Velly ovvero la speranza del niente, in Jean Pierre Velly, catalogo della mostra, Galleria Don Chisciotte, Roma 1988, p. 3
[3] Paul Valery, in Jean Clair, op.cit.
[4] Maxime Préaud, Mélancolies, Livre d’images, ed. Klincksieck, 2005
[5] La bile nera potrebbe essere associata per similitudine all’inchiostro dell’incisore. Jean Starobinski titola il suo contributo a Mélancolie, folie et Génie en Occident: L’encre de la Mélanconie, dove egli paragona la bile nera ad un’ «acquaforte dello Stige interiore». Op. cit, p. 24
[6] Una decina delle quali inedita.
[7] I temi erano i seguenti: grotteschi, paesaggi, nudi femminili e vanità.
[8] «Mi piacerebbe molto che non ne restasse traccia, poter eliminare dal mio lavoro assolutamente ogni storicità. Significherebbe giungere a un discorso ben più ampio, più umano. È quello che mi accanisco a fare. Quando ho una matita in mano voglio disegnare, cogliere la cosa più anonima che ci sia. Questo sarebbe il mio ideale. » (Dialogue de Jean Marie Drot avec Jean-Pierre Velly, in «Villa Medici. Journal de voyage», anno III, n.7-8, dicembre, ed. Carte Segrete, Roma 1989, pp.15-28.)
[9] «Ho cominciato a incidere all’età di quattordici anni all’Ecole des Beaux Arts e mi sono immediatamente reso conto che l’incisione era per me il modo migliore di esprimermi, che sarebbe stata la mia strada. Ma lo choc più forte l’ho avuto quando per la prima volta alla Biblioteca Nazionale di Parigi ho potuto vedere e toccare le incisioni del grande, dell’insuperabile e sublime Dürer. Questa fu la rivelazione della mia vita. E da allora l’incisione è stata l’incubo e il sogno della mia vita. La visione in nero e bianco è un fatto interamente mentale: essa non esiste in natura e nel bianco e nero si scatenano tutta la mia ansia e la mia sete di espressione artistica, senza seguire le mode né volere ad ogni costo cercare di essere contemporaneo. Lo sono già abbastanza restando me stesso con tutto il mio bagaglio di immagini e di visioni».
(Jean-Pierre Velly, parole raccolte da Franco Simongini, I miei maestri, in «Il Tempo» , Roma 28 novembre 1980)
[10] Conservato al Musée Unterlinden di Colmar.
[11] Non si ricorderanno qui i rapporti che esistono fra il Malinconico e il Maligno; evochiamo soltanto il detto «Melancholia balneum diaboli» che fa del malinconico una vittima prediletta di Satana.
[12] Riprodotta in: Maxime Préaud, op. cit., p. 63. Una diavolessa dai seni cadenti e dalle mani artigliate tormenta Giobbe seduto in atteggiamento malinconico (cf. in fondo a questa pagina).
[13] « Per me un maestro è colui che ha il coraggio di andare fino in fondo a sé stesso. Più il terreno da cui nasce il pensiero è umano e fertile, più il pensiero sarà profondo, più grande sarà l’autenticità.» (Dialogue de Jean Marie Drot avec Jean-Pierre Velly, in «Villa Medici. Journal de voyage», anno III, n.7-8, dicembre, ed. Carte Segrete, Roma 1989, pp.15-28.)
[14] Si riscontrano degli esemplari di Rechute firmate e numerate in entrambi i sensi. Nel catalogo ragionato compilato da Didier Bodart nel 1980, con la collaborazione attiva dell’artista, essa è riprodotta con gli uomini che cadono nel baratro.
[15] Dafne si trasforma in alloro, Atteone in cervo, Aracne in ragno.
[16] V. Sgarbi, op. cit.
[17] Dialogue de Jean Marie Drot avec Jean-Pierre Velly, in «Villa Medici. Journal de voyage», anno III, n.7-8, dicembre, ed. Carte Segrete, Roma 1989, pp.15-28.)

Hans Baldung-Grien
Giobbe, silografia 1509

Jean-Pierre Velly
Maxime Préaud, Mélancolies, livre d’images, Ed. Klincksieck, 2005, p. 62-63
vedere gli albums su Saturno e l’Alchimia