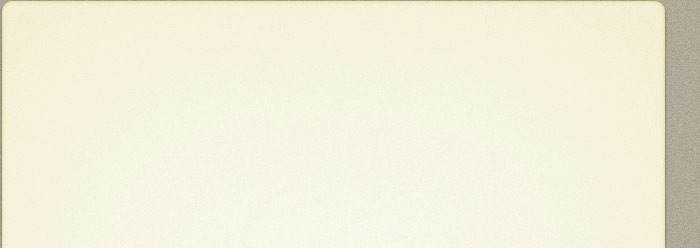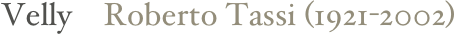Roberto Tassi
Vessili della natura (1989)
È stato Dürer per primo: ha posto l’occhio acutissimo su una zolla di prato in cui erano nati foglie larghe e steli sottili, qualche fiorellino selvatico, o un giallo ranuncolo, un’aquilegia; l’ha divelta, isolata, ne ha fatto il soggetto di acquerelli nitidi, folti e luminosi, come fosse una Madonna, un Santo un cavaliere; ha riprodotto la realtà più modesta, fibra per fibra, atomo per atomo, trasfigurandola in un allucinato, sacro, frammento di assoluto. Basta al pittore uscire di casa, avviarsi per un viottolo di campagna.
Jean-Pierre Velly, che riconosce come silo ispiratore quell’antico alto magistero, raccoglie un cespo d’erba, un mazzetto di fiori, li porta nello studio e mentre stanno lentamente seccando, ne trae immagini ricche, fantasiose, minutamente vibranti, splendide di un colore che si è internato in essenza stessa dell’oggetto, toccate dalla lievissima anemia della vita che va spegnendosi.
Come tutti i veri poeti Velly è fuori dal suo tempo, lontano, rintanato, perduto, insonne; ma quella febbre che lo rende vigile, quel distacco che dissolve la speranza, quella malinconia che lo nutre, lo spingono entro il cuore del tempo, da dove manda, segnali misteriosi e poco compresi, questi grandi fogli di acquerello.
E quando i giochi saranno fatti e la giustizia degli anni avrà cancellato tanta arte poco misteriosa e molto compresa, le avanguardie i finti realismi e i finti formalismi, gli acquerelli di Velly resteranno a raccontare come nasceva la struggente poesia della nostra epoca; non tanto diversamente da quelli di Dürer.
Questi acquerelli non sono nati all’improvviso, la loro bellezza così felicemente raggiunta non ha una gestazione felice né semplice. Si distende alle loro spalle un lungo, minuto, ventennale lavoro di incisione, un corpus grafico anch’esso prodigioso e sconosciuto, come fosse uscito dall’antro di un mago paziente e addolorato.
Quelle incisioni rivelano una preparazione tenacissima, interminabile, feroce; hanno caratteristiche inattese, la fantasia agitata, la drammaticità delle metamorfosi, la moltiplicazione infinita del segno che allarga grandi spazi, dove sterminati accumuli di nuvole, di fantasmi, di uomini, di erbe, di oggetti abbandonati, di onde, di macerie, di immondizie, danno una testimonianza vertiginosa del nostro tempo una profezia tragica di quello futuro. Mirabili di tecnica, eccitate di invenzione, anch’esse hanno dei santi protettori che, oltre al citato Dürer, mi sembrano essere Grunewald, Hercules Seghers e Bresdin.
Negli acquerelli il lungo lavoro dell’opera grafica è presente senza vedersi, presente in assenza; è quel lavoro che crea come un terreno, uno spessore, un’invisibile materia, su cui si posano, e su cui prendono consistenza, la levità, la delicatezza, la luce, l’espansione aerea, lo spazio infinito, la micrografia palpitante, degli acquerelli. L’opera grafica è presente nella mano che traccia minuti tratteggi con pennelli sottilmente acuminati, nello spirito che vede l’immensa pullulazione della natura.
A Velly basta l’avvio di pochi fiori, di qualche stelo, solo un mazzo di erbe tanto comuni da restar sconosciute, per suscitare quella immensità: un ramo di alchechengi, queste lanterne rossastre della natura, alcuni soffioni, un caprifoglio, un bocciolo di cardo, foglie lanceolate, uno stelo di ortica, una margherita di campo, un fiore di pisello selvatico, un cespo di viole, un gambo di ciclamino. Li dipinge uguali, riconoscibili, ma totalmente diversi, estratti e salvati dal processo organico e dal flusso del tempo, incantate e preziose reliquie poste su un tavolo, su una balaustra o in una nicchia come su un piccolo altare.
Con la minuta perfezione della sua infallibile mano persegue ogni filo, ogni peduncolo, ogni pistillo, e le lacerazioni delle foglie, l’esplosione dei semi, ricami degli insetti, come se dipingesse tutte le fibre vegetali, le cellule vegetali, in un formicolio di segni, in un ronzio di piccoli tratti. La vita naturale pullula infinitamente in questo quasi religioso rispetto del particolare, che è come una coscienza morale.
Ma quando l’opera è terminata e noi la guardiamo, ogni minuzia si annulla e partecipa, annullandosi, al canto fermo, luminoso, molteplice, dell’insieme: i fiori e le erbe mantengono la loro precisione ma assunti ormai al cielo fantastico delle apparizioni; sono se stessi e i fantasmi colorati di se stessi; sono oggetti ed essenze; frammenti di natura ed epifanie dello spirito. Assediati, e liberati, dalla luce, si espandono nel suo grembo e sembrano a volte condensazioni, accidenti della luce, sprigionamenti di luce.
A volte respirano stretti tra due opposte fonti luminose: quella anteriore che li fissa nella loro irregolare, libera e perfetta composizione, gettando lievi ombre azzurre appena grigie sul piano che li sostiene; ed una posteriore, che viene dalle profondità sconosciute dell’opera, che scende dall’alto, da un cielo passante insensibilmente dal blu all’azzurro al rosa al giallo, e li aureola appena di un alone argentato, di uno splendore trasparente, consegnandoli così a quella levitazione dove potranno in eterno consistere. Proprio come se dietro quei mazzi d’erbe e fiori si stendesse, mostratesi solo per la luminosità che emana, un grande spazio naturale.
Ma più spesso quello spazio si mostra intero: si apre allora nell’opera di Velly un respiro vastissimo, un’ansia d’infinito, come si era visto solo nei paesaggi di alcuni romantici del nord: cieli folti di nuvole, palpitanti di stelle per una luce impalpabile di luna che schiarisce appena la pianura del mare segnando l’ondulazione silenziosa di una calma notte. Sembra che debba nascere un contrasto tra questi vessilli della natura deposti qui vicino a noi e, della natura, quell’ansimare potente e lontano tra nuvole e acque. Ma nella natura e nell’arte i contrasti si confondono, si uniscono e trasfigurano, creano poesia. Lo spazio che nasce dietro di loro, lambisce questi reperti vegetali e li risucchia nella sua vastità, li fa partecipare, umili e alteri come sono, alla grande circolazione delle luci, delle notti, delle stagioni, al grande moto del cosmo.